L’industria del dolore
Lo scandalo che coinvolge alcune
note ONG che si occupano di aiutare le popolazioni colpite da povertà, da disastri naturali, etc ha lasciato
molti con l’amaro in bocca. Ma come, si chiede la opinione pubblica, versiamo denaro
per aiutare i più deboli ed invece queste persone li sperperano per andare con
le prostitute? Ma come è possibile che i volontari facciano queste cose?
Come in tutti i settori l’industria
del dolore ha le sue pecore nere, i suoi punti deboli il primo dei quali
risiede nella selezione del personale. Una qualsiasi grande organizzazione
umanitaria, ha bisogno, oltre che dei volontari e delle persone di buona
volontà, anche di una enorme quantità di
manodopera specializzata che serve ai per organizzare, costruire, curare. Tradotto in termini pratici servono
medici, infermieri, ingegneri, geometri, elettricisti, falegnami, contabili etc…
Per una parte di questo personale
si tratta solo di lavoro. Lavoro all’estero, ben pagato, che non ha niente a
che fare con la carità, con l’altruismo. Ma la gente pensa che per lavorare per
“Oxfam” “Save the Children”, per citarne
due delle più famose, devi essere una persona incline alla beneficenza. Niente
di più sbagliato. Sono solo persone che hanno trovato un lavoro e magari anche
un buono stipendio. Per cui non stupitevi che anche tra le ONG ci siano mele
marce. Il volontariato si fa quotidianamente rispettando le persone che ti
circondano, aiutandole, curandole. Anche con i conti correnti, ma soprattutto
ci deve essere un rapporto diretto tra le persone: un sorriso fa molto di più che
elemosinare qualche soldo. Spendere una parte del proprio tempo per gli altri
serve anche a chi il tempo lo regala.
Questo stupore nell’apprendere
che anche le ONG fanno “le cose brutte” mi fa venire in mente un altro lavoro
in cui spesso si crede che chi lo fa dev’essere attratto dal Sacro Fuoco della
giustizia sociale e della lotta alle ingiustizie. E’ il giornalista e il
fotografo. Una volta gli inviati veri (come Ryszard Kapuściński) andavano a proprie spese a
raccontare per esempio, l’Africa. Poi c’erano gli inviati dei network
occidentali che avevano più soldi che comunque si facevano mandare nei posti a
seguito di storie che interessavano il mondo intero, ma anche in loro si
trovava lo spirito umanitario, la voglia di raccontare i cambiamenti e le ingiustizie.
E così “il circo mediatico” si incontrava nei posti più caldi del mondo per
raccontare, far conoscere angoli del mondo, che nessuno magari conosceva, dove
una guerra o una carestia, quelli che oggi chiamiamo disastri umanitari. C’erano
i lettori che leggevano e guardavano le rozze, ma efficaci, immagini di quei
disastri e il servizio di informazione arrivava attraverso i giornali, le
televisioni, gli speciali su un argomento. Adesso l’industria del dolore ha
bisogno di immagini forti e di premiare chi riesce a fare impietosire di più,
ai colori del Caravaggio o alla Pietà del Michelangelo, ma del contenuto, non
interessa più ne ai lettori ne’ tantomeno ai premiati fotografi e giornalisti. Oggi
premi e mostre e festival non raccontano l’orrore e il dolore, ma premiano ed espongono il più bell’orrore e dolore che
siano stati ripresi nel corso di un anno da fotografi che non hanno più come
riferimento i lettori, ma giurie di premi e direttori di festival.
E tutti insieme non pensiamo più ai morti e alle
ingiustizie, ma come siamo stati bravi a raccontarle. I premi per i fotografi e
per i giornalisti sono come le stelle Michelin per i cuochi. Tutto fumo e
niente arrosto.


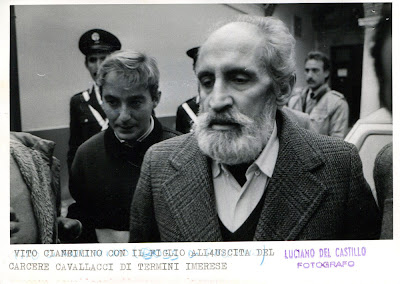
Commenti